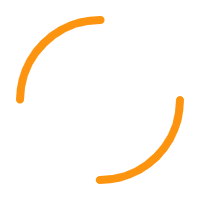Descrizione
Seminario-BQ/Corso opzionale (2)-BT. AI e Digital HumanitiesObiettivi
Al termine del corso lo studente è in grado di ricercare ed esaminare criticamente materiali, fonti bibliografiche e documentarie in formato digitale di tema storico-religioso, con particolare attenzione alla sfera biblica, su cui condurre ricerche. Sa comunicare in forma scritta e orale le conoscenze acquisite nel campo delle Digital Humanities (DH) e dell’Intelligenza Artificiale (AI) utilizzando registri di comunicazione adeguati ai diversi contesti di riferimento e tenendo conto dei destinatari a cui si rivolge. È in grado di dare forma, anche progettuale, ai risultati delle proprie ricerche documentando in modo accurato e completo le informazioni su cui basa le proprie conclusioni e dando conto delle metodologie e degli strumenti d’indagine utilizzati.
Programma
Partendo dallo sviluppo storico-concettuale dell’informatica umanistica, il corso intende avviare alle questioni metodologiche e strategiche che la transizione digitale ha portato e sta portando nelle scienze religiose. Durante le lezioni verranno esplorati tanto l’approccio «strumentale» alle DH, con presentazione dei principali strumenti consolidati e momenti laboratoriali dedicati all’uso di tali tecnologie, quanto l’approccio «metodologico» e «sperimentale» che è parte intrinseca dell’informatica umanistica sin dalle sue origini, ed è il solo che può farne costantemente crescere il potenziale, generando vera innovazione metodologica e culturale.
In particolare, i contenuti del corso riguarderanno:
-
- Introduzione all’informatica umanistica: definizione, paradigmi, storia, ruolo istituzionale nel contesto italiano, anche in relazione alle politiche culturali della transizione digitale.
- Oggetti, linguaggi, strumenti, metodi per l’organizzazione e la preservazione della conoscenza.
- Internet per l’antichità greco-romana: presentazione di repertori bibliografici, spogli online, indici generali e specifici, motori di ricerca e banche dati per i testi letterari latini e greci e per i testi documentari (papiri e iscrizioni), con speciale attenzione agli strumenti per lo studio e l’analisi delle fonti delle tradizioni cristiane (soprattutto scritti biblici e patristici). Sono previsti momenti laboratoriali con esercitazioni individuali degli studenti, sotto la guida della docente, su queste tecnologie.
- Presentazione di RESILIENCE, l’infrastruttura di ricerca europea per le scienze religiose entrata nella Roadmap ESFRI nel 2021, e di alcuni progetti a essa connessi. Questa presentazione mostrerà come la comunità scientifica delle scienze religiose possa trasformarsi da mero agente dell’implementazione di tecnologie consolidate a (pro)motore di una nuova partita da giocarsi nel mondo digitale, nell’incontro con ciò che attualmente possono offrire l’Intelligenza Artificiale, i Big Data e lo High Performance Computing.
- Gli studi sulle Bibbie e sulla letteratura cristiana antica nell’era delle DH e dell’Intelligenza Artificiale: nuove domande, potenzialità e problematiche. In particolare, verranno analizzati alcuni progetti di settore per enucleare le caratteristiche specifiche del processo di costruzione di un percorso scientifico che faccia convergere i metodi di ricerca delle scienze religiose e quelli digitali.
Dall’illustrazione ed esplorazione di questi contenuti deriveranno: la conoscenza di vari strumenti e servizi (in continua evoluzione) che supportano la creazione, l’organizzazione, la preservazione, la condivisione e l’uso dei dati nel campo degli studi storico-religiosi; una visione consapevole del ruolo svolto dall’informatica umanistica nel ripensamento di alcuni processi di ricerca e nella produzione di nuova conoscenza nell’ambito delle scienze religiose; uno sguardo critico sulle sfide che le scienze umane possono lanciare oggi a chi studia ICT proprio grazie alla complessità dei dati di cui le prime dispongono.
Avvertenze
Non sono richieste conoscenze pregresse.
Tipo di corso: Le lezioni saranno di tipo frontale-espositivo; sono previsti però anche momenti laboratoriali, con analisi e navigazione nelle risorse digitali online ed esercitazioni personali degli studenti, sotto la guida della docente, sugli strumenti e sui metodi illustrati a lezione.
Tipo di esame: L’esame consiste in una prova pratica seguita da un colloquio orale, che si svolgeranno in un unico momento: lo studente dovrà presentare un caso di studio che implichi l’uso critico e consapevole di alcune delle tecnologie e metodologie apprese durante le lezioni, e sintetizzarlo in massimo 7 slide (10 min circa); la discussione orale prenderà avvio da questo caso pratico ideato dallo studente e verterà sui temi illustrati durante il corso e trattati nella bibliografia indicata.
Si valuteranno pertanto: la conoscenza e la padronanza degli argomenti discussi durante le lezioni e della bibliografia di riferimento indicata, la capacità di sapersi esprimere adeguatamente usando il lessico specifico della materia trattata, la capacità di sintesi e di analisi dei temi e dei concetti, l’abilità nell’utilizzo pratico degli strumenti mostrati durante il corso, e infine le capacità critiche e metodologiche maturate dallo studente.
Docente
Anna MAMBELLI
Bibliografia
La bibliografia d’esame per gli studenti prevede:
1) Ciotti F. (a cura di), Digital Humanities. Metodi, strumenti, saperi, Carocci, Roma 2023, in particolare pp. 1-254 e 312-324 (previo accordo con la docente, uno o più dei restanti capitoli possono essere studiati e discussi in sede d’esame se rientrano negli interessi specifici dello studente; in tal caso, si richiede soltanto un saggio tra quelli proposti nel punto 3).
2) Salvarani R., «Studi storico-religiosi e Digital Humanities: implicazioni critiche e metodologiche», in PATH – Pontificia Academia Theologica 19(2020)1, 125-137.
3) Due tra i seguenti saggi:
a) Clivaz C., The Bible in the Digital Age: Multimodal Scriptures in Communities, in Hutchings T. – Clivaz C. (a cura di), Digital Humanities and Christianity: An Introduction, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 21-45 [DOI: https://doi.org/10.1515/9783110574043-002].
b) Schroeder C.T., «The Digital Humanities as Cultural Capital: Implications for Biblical and Religious Studies», in Journal of Religion, Media and Digital Culture 5(2016)1, 21-49. [DOI: https://doi.org/10.1163/21659214-90000069].
c) Mellerin L., New Ways of Searching with Biblindex, the Online Index of Biblical Quotations in Clivaz C. – Gregory A. –Hamidović D., Early Christian Literature, in Digital Humanities in Biblical, Early Jewish and Early Christian Studies, Brill, Leiden-Boston 2014, 177-190. [DOI: https://doi.org/10.1163/9789004264434_012].
d) Prato G.L., «Gli scritti biblici tra utopia del canone fisso e fluidità del testo storico», in Fiormonte D. (a cura di), Canoni liquidi. Variazione culturale e stabilità testuale dalla Bibbia a Internet, con la collaborazione di Bianca Ruggeri, ScriptaWeb, Napoli 2011, 43-61.
e) Ess C., «Revolution? What Revolution?». Successes and Limits of Computing Technologies, in Schreibman S. – Siemens R. – Unsworth J. (a cura di), Philosophy and Religion, in A Companion to Digital Humanities, Blackwell, Oxford 2004, 133-142. [http://www.digitalhumanities.org/companion/]