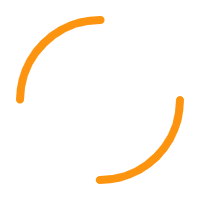Nuovi corsi di Licenza 2025/2026
La Licenza in Sacra Teologia della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna è la laurea di II livello degli studi teologici che ha come scopo immediato quello di offrire una vasta gamma di approfondimenti nei tre ambiti di ricerca teologica attivi all’interno della nostra Facoltà: l’ambito della Teologia dell’Evangelizzazione, quello della Storia della Teologia e l’ambito della Teologia Sistematica. Ciascuno secondo la propria peculiarità e grazie all’impegno quasi ventennale di una comunità accademica aperta alle più diverse collaborazioni, i tre percorsi dell’unica Licenza in Sacra Teologia si prefiggono di fornire una serie di competenze utili non solo per una formazione che possa condurre all’insegnamento delle discipline teologiche, ma anche per valorizzare l’impegno nella programmazione e nell’esperienza pastorale e, così pure, per arricchire quei profili professionali che debbono confrontarsi con la complessità del fenomeno religioso nella nostra società.
Il corso di Licenza è quindi un percorso di specializzazione di durata biennale in cui si alternano corsi comuni erogati dai tre Dipartimenti della Facoltà (Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione, Dipartimento di Storia della Teologia e Dipartimento di Teologia Sistematica) e corsi caratterizzanti i tre indirizzi di approfondimento. Per maggiori informazioni si veda questa pagina del sito.
CORSI COMUNI

La Bibbia nell’Antropologia teologica: problemi emergenti e chiavi ermeneutiche
prof. Federico BADIALI
«Lo studio della sacra Pagina sia come l’anima della sacra teologia» (DV 24). Questo era, sessant’anni fa, l’auspicio formulato dal concilio Vaticano II circa il ruolo della Bibbia nella ricerca teologica. Bisogna riconoscere che, in questo campo, il cammino compiuto da allora è stato davvero considerevole. Oggi, però, la teologia deve misurarsi con sfide inedite, soprattutto per quanto concerne l’antropologia teologica.

Mistero e reciprocità. La Teologia sacramentaria della Commissione Teologica Internazionale
prof. Pierre GALASSI
Il corso si propone di approfondire la teologia sacramentaria elaborata dalla Commissione Teologica Internazionale (CTI), con particolare attenzione ai temi del mistero e della reciprocità nell’economia sacramentale. Attraverso lo studio dei documenti della CTI, si intende esplorare il nesso tra fede e sacramenti, la dimensione ecclesiale dei segni sacramentali e il loro radicarsi nella Rivelazione e nella Tradizione, in dialogo con il pensiero contemporaneo.

Il Libro dei Dodici e le sue teologie
prof.ssa Donatella SCAIOLA
Il corso ha due obiettivi fondamentali; il primo è di natura metodologica, mentre il secondo è contenutistico. Attraverso lo studio di un corpus particolare, il Libro dei Dodici, intendiamo, in primo luogo, riflettere su come interpretare un testo apparentemente così eterogeneo (obiettivo metodologico), anche ricostruendo la storia recente della ricerca dedicata a questo libro. In secondo luogo, presenteremo i principali temi teologici che sono stati proposti come significativi per la comprensione del libro (il «giorno del Signore»; la formula di Es 34, 6-7; l’elezione di Israele e il suo rapporto con le nazioni; la conversione, ecc.). Al termine del percorso proporremo una possibile chiave di lettura di questo insieme testuale.

Lessico, metafore e simboli della giustizia nel Vangelo di Giovanni
prof. Davide ARCANGELI
L’obiettivo del corso è offrire un’analisi approfondita dei capitoli centrali del QV (5–12) sotto la lente della controversia profetica bilaterale (Rib), per mostrare come l’autore intenda descrivere il rapporto tra Gesù e i suoi avversari, non tanto nella forma di un giudizio di condanna reciproco, quanto piuttosto nella forma di una controversia che mira alla riconciliazione. Questo approccio permette di intravedere un possibile attraversamento e superamento della crisi ideologica e relazionale che la proposta di Gesù provoca, in un dibattito che si colloca all’interno del giudaismo del tempo. Dal punto di vista teologico il corso cercherà di chiarire anche come la giustizia per il QV sia strettamente connessa al percorso di riconoscimento della verità messianica in Gesù di Nazaret (anagnorisis), in una stretta correlazione tra il processo di illuminazione delle opere malvagie nel mondo e il passaggio della libertà umana dalle tenebre alla luce. Si concluderà affermando che nel QV non vi è predestinazione negativa ma solo positiva, per la salvezza. Infine nella proposta di Gesù vi è rottura con le istituzioni giudaiche del tempo di Gesù, né sostituzione, ma un compimento che porta con sé un’uscita dalla crisi prodotta per un’interpretazione ideologica delle stesse.

Il Simbolo degli apostoli e i suoi contenuti: storia e dottrina
prof. Davide RIGHI
Far conoscere la storia dei simboli della fede, dai primi simboli già presenti nel Nuovo Testamento ai simboli elaborati in funzione anti-gnostica nel II secolo, al «Simbolo degli apostoli» frutto della vita della Chiesa di Roma nel III secolo e i motivi dell’introduzione del Credo all’interno della celebrazione eucaristica.
La formulazione sintetica della fede nel Nuovo Testamento. La regula fidei riportata nell’Adversus Haereses di Ireneo di Lione, il simbolo apostolico della fede elaborato dalla Chiesa di Roma e la leggenda ad esso collegata; i singoli articoli di fede; la fortuna del «Simbolo degli apostoli» nell’antichità; il dibattito sul simbolo apostolico tra XVI e XIX secolo; utilizzo del «Simbolo degli apostoli» in epoca contemporanea.

«Deus est bonum commune totius universi et omnium partium eius». La nozione teologica di bene comune lungo la tradizione cristiana
prof. Fausto ARICI
Si cercherà di definire in termini teologici la nozione di bene comune, ripercorrendo storicamente gli snodi essenziali della sua trattazione.La lunga storia della nozione di bonum commune, a partire da Seneca (cf. De clementia, I, III, 2) sino al concilio Vaticano II (cf. Gaudium et spes, n. 26), passando per le differenti teorizzazioni di Agostino, Tommaso, senza dimenticare le disparate loro riproposizioni, tratteggia sostanzialmente il perseverante sforzo di rendere ragione di una serie di tensioni sostanzialmente intrinseche al concetto stesso di bonum commune: quella fra utilitas e bonum, quella fra bene proprio e bene di tutti, quella fra bene della maggioranza e bene del più bisognoso, quella fra bonum societatis e summum bonum. L’intento del corso è quello di verificare come tale nozione, con tutte le sue intrinseche tensioni, possa essere colta innanzitutto secondo una cifra pienamente teologica e quindi capace, al tempo stesso, di avere una sua specifica pertinenza etica, politica ed economica.
CORSI CARATTERIZZANTI: Storia della Teologia

Il celibato dei chierici. Origine, prassi e teologia (secc. I-V)
prof. Sincero MANTELLI
Ripercorrere la storia della formazione del celibato clericale, delle motivazioni ideali e pratiche di tale forma di vita dalle origini fino al V secolo. L’indagine si compone di due parti. Anzitutto la ricerca storica sull’origine del celibato dei chierici nella Chiesa antica (I-V secolo) e le motivazioni ideali a sostegno di tale prassi. A seguire – in forma seminariale – l’approfondimento dei fondamenti scritturistici e delle principali esposizioni esegetiche impegnate a fornire una base argomentativa alla singularitas degli ecclesiastici, principalmente in riferimento allo scritto pseudociprianeo De singularitate clericorum.

Per una teologia mistagogica della liturgia eucaristica. I padri greci
prof. Francesco PIERI
L’approccio mistagogico al rito non è limitato soltanto agli scritti dei secc. IV e V, ma è riconoscibile nelle opere antecedenti dell’antichità patristica e prosegue negli autori bizantini. Esso trova un ambito privilegiato della sua applicazione non solo nella liturgia battesimale, ma anche in quella eucaristica e si caratterizza per la stretta interdipendenza che scopre tra azione liturgica, Scrittura e interezza dell’economia salvifica.
Il corso si propone di contestualizzare storicamente e teologicamente le più antiche testimonianze raccolte dalla grande antologia curata da L. d’Ayala Valva, ove esse figurano in base ad un criterio tematico.

Percorsi con testi scelti di Anselmo, Tommaso, Bonaventura, Scoto
prof. Fabio GAMBETTI
Il corso di Storia della Teologia medievale si propone di offrire un’introduzione critica e storicamente contestualizzata allo sviluppo della riflessione teologica nel medioevo latino, con particolare attenzione ai principali autori, alle scuole e ai temi che hanno segnato questa epoca feconda della tradizione cristiana.

Pensare Dio nella storia. Ritratti di teologi contemporanei
prof. Giorgio SGUBBI
Prima e dopo il concilio Vaticano II la teologia cristiana ha vissuto una stagione intensa, feconda e ricca di stimoli e prospettive rinnovate.
Il corso vuole offrire allo Studente di teologia alcuni ritratti di teologi significativi, il cui contributo è stato incisivo e determinante per lo sviluppo stesso del sapere teologico. Il tutto nell’intento di indicare come contesto, critiche e proposte innovative hanno condotto la teologia ad una maggiore consapevolezza della sua originalità, ricchezza e collocazione nell’orizzonte antropologico e sociale dell’umana esistenza.

La poliedricità del giudaismo in epoca greco-romana
prof. Marco SETTEMBRINI (COORD.)
Il seminario, condotto da un team di esperti, esplora la complessità del giudaismo nell’epoca greco-romana attraverso un’analisi approfondita di fonti letterarie e materiali di diversa provenienza. Attraverso l’esame di testi e reperti significativi, verranno messe in luce le peculiarità di diverse aree geografiche e di speciali sinergie culturali, considerando la Galilea, la Samaria, la Giudea, Alessandria e Babilonia.
CORSI CARATTERIZZANTI: Teologia dell'Evangelizzazione

La morte nel contesto globale contemporaneo. Aspetti biblici, filosofici, teologici e sociali
prof. Pier Luigi CABRI
La questione della morte apre a diversi approcci: la psicologia, la filosofia, la teologia e la spiritualità, oltre al sociale, se ne interessano, dando la loro visione e il loro apporto specifico.
Il corso intende presentare e verificare criticamente concezioni appartenenti al passato e nuovi punti di vista sulla morte con i quali il pensiero contemporaneo e la coscienza cristiana devono confrontarsi. Ci si propone, inoltre, di valorizzare la presenza, tra gli studenti, di culture non europee, che – rispetto alla tradizione occidentale – hanno un modo differente di avvicinarsi a questo tema e ciò potrà essere motivo di ulteriore analisi, confronto e approfondimento.

«Non passa lo straniero»? I paradigmi antropologici del fenomeno migratorio globale compresi alla luce dell’antropologia relazionale. Sfide e opportunità per l’evangelizzazione
prof. Paolo BOSCHINI
Dal 2008 questo famoso verso della canzone patriottica italiana La leggenda del Piave (1918) è diventato uno dei più frequenti slogans politico-culturali di coloro che contrastano i processi migratori in atto in Europa, sostenendo che essi sono di fatto un’«invasione» destinata a snaturare le tradizioni culturali, l’organizzazione sociale e finanche il patrimonio genetico dei popoli europei.
Dopo una ricostruzione demografica e sociologica del fenomeno migratorio verso l’Europa (e l’Italia in particolare) nel primo quarto del XXI secolo, attraverso il ricorso ad autori significativi, il corso analizza i quattro principali paradigmi antropologici, sottesi ai più diffusi orientamenti presenti nelle opinioni pubbliche dei paesi europei a proposito del fenomeno migratorio globale: 1) conflitto; 2) apartheid; 3) integrazione; 4) ospitalità.
Nella parte conclusiva, il corso presenta un’interpretazione filosofica della questione migratoria globale nella prospettiva dell’antropologia relazionale: si propone una riflessione culturale su sfide, opportunità e questioni aperte per l’evangelizzazione in un’Europa sempre più meticcia. Il corso si conclude con l’iniziativa extracurricolare «Nessun cibo è straniero» – agape fraterna aperta a tutta la comunità accademica, in cui ogni partecipante condivide con gli altri un cibo del proprio popolo.

«Accedunt deinde orationes» (OGMR 30). Studio dell’eucologia minore nel Messale Romano: l’orazione di colletta
prof. Stefano CULIERSI
Dopo aver introdotto alla conoscenza dei diversi metodi di studio dell’eucologia, il corso si propone di condurre gli studenti allo studio dell’orazione di colletta nel Messale Romano, a servizio della «partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa alla celebrazione» (cf. SC 11). Attraverso approcci storici, linguistici, teologici e antropologici, si prenderanno in considerazione diversi esempi della liturgia romana invitando gli studenti ad appropriarsi di questi strumenti, dimostrando di saperli utilizzare in un esercizio di verifica su una orazione determinata.

L’ecologia integrale come progetto di pace, giustizia e fraternità
prof. Matteo PRODI
L’obiettivi del corso è raccogliere profondamente la sfida che la casa comune pone a tutta l’umanità. L’ambiente è la sentinella che grida all’uomo il bisogno di cambiare rotta. Non è solo questione di fare delle scelte green ma di cambiare realmente la traiettoria verso il futuro, progettando, a partire dal creato, una umanità capace di pace, giustizia e fraternità.

Cattolicesimo e modernità in Occidente: Stati Uniti e dintorni
prof. Massimo FAGIOLI
L’obiettivo è di familiarizzare gli studenti coi momenti, nomi e temi principali nella teologia cattolica in Nordamerica (specialmente Stati Uniti) negli ultimi cento anni – tanto più necessario dopo l’elezione del primo papa dagli Stati Uniti, Leone XIV. La questione cattolica americana ha cambiato di segno più volte nel tempo nel corso dell’ultimo secolo, e oggi nel secolo XXI assume caratteristiche contraddittorie e nuove, essenziali per comprendere i rapporti tra il papato e la Chiesa cattolica globale.

Intelligenza artificiale e nuovo umanesimo
prof. Valentino MARALDI
Il corso si propone di presentare il contributo della antropologia teologica al fine di raccogliere gli interrogativi e le sfide provenienti dai sistemi artificiali intelligenti in quanto tecnologie del sé, con particolare attenzione alle trasformazioni che possono riguardare la sfera relazionale umana, tanto la relazione col divino, quanto le relazioni interpersonali e sociali.
La riflessione antropologica sarà indirizzata a integrare positivamente la rivoluzione digitale in un nuovo umanesimo che ponga al centro il concetto di «vita», nella sua valenza teologica, come orizzonte di sviluppo e di speranza.
La prospettiva del «vivens homo», opponendosi a riduzioni funzionalistiche, produttivistiche o efficientistiche dell’umano, contrarie alla dignità e allo sviluppo integrale della persona umana, si mostrerà rilevante anche per un’etica della IA.
CORSI CARATTERIZZANTI: Teologia sistematica

Cristologie contestuali: l’unità di Cristo come sinfonia differita
prof. Claudio MONGE
Con la stagione dei grandi concili ecumenici (a partire da Nicea nel 325 d.C.) si affronta la questione dello statuto teologico di Gesù, figlio di Dio, che fino ad allora non era stato ancora fissato, dando luogo ad aspre controversie che, in qualche modo, minavano anche la pax imperiale. In sostanza, sullo sfondo di questa contesa teologica emergono tutte le implicazioni politiche, sociali e culturali che essa portava con sé. Certo, si può restare sorpresi dall’atmosfera piena di complotti politico-teologici, dalle violenze e i tumulti che percorsero la Chiesa del IV secolo. Eppure, nei testi evangelici, incentrati sulla vicenda cristologica, non solo non troviamo alcun riferimento esplicito ad una trinità in Dio ma neppure alcuna speculazione «cristologica» in senso tecnico, cioè una totale assenza di una esplicita dottrina sulla persona di Cristo.

I nomi del Figlio: Verbo e Immagine. Dalla riflessione logico-grammaticale al riflesso culturale
prof. Giuseppe BARZAGHI
Esiste una inculturazione della fede e una acculturazione della stessa. I due processi si rispecchiano e si arricchiscono allo stesso tempo. Il formale del discorso teologico trinitario è investito da questa duplice esigenza e innesca vie sempre più ricche per la predicazione.

«De dignitate intellectus» (GS 15). Custodire il senso integrale dell’essere umano nel tempo dell’Intelligenza artificiale
prof. Marco SALVIOLI
Uno dei compiti della teologia è certamente quello di porsi al servizio del doveroso discernimento che la Chiesa esercita nei confronti dei «segni dei tempi» per interpretarli alla luce del vangelo (GS 4). Prendendo atto dell’attuale sviluppo dell’intelligenza artificiale, il corso intende offrirne le coordinate per un dialogo con l’antropologia teologica d’ispirazione tomista al fine di riconoscere la dignità dell’intelligenza umana (GS 15) e la differenza ontologica che la separa dal suo simulacro altamente performante.

Vita sacramentaria e prassi pastorale nella Chiesa di Antico Regime (XVI-XVIII sec.)
prof. Gianni FESTA
Questo corso intende offrire un quadro, chiaro e il meno possibile allusivo, degli aspetti, delle vicende, delle prassi pastorali e delle istituzioni principali della vita cristiana in età moderna. La Riforma cattolica e la Riforma protestante ebbero come scopo principale quello di evangelizzare e cristianizzare il popolo di Dio ricorrendo soprattutto alla predicazione e catechesi e alla rete dei sacramenti: si trattò, in ambito cattolico, di un vero e proprio disciplinamento della pratica cristiana, caratterizzata da una robusta dimensione comunitaria, e controllata nelle visite pastorali. Se si eccettuano alcune personalità marginali, nessuno nei secoli XVI-XVIII concepisce che il cristianesimo possa essere professato o vissuto in altro modo che comunitariamente. Di norma la comunità cristiana si confonde con la società civile: sono il villaggio, la città, la comunità, il regno a vivere solidalmente il proprio rapporto con Dio, secondo i riti e le devozioni codificate dalla Chiesa, ed è grazie alla loro pratica disciplinata e con l’ausilio della predicazione e della catechesi che viene comunicata ai fedeli la grazia divina.

Sessualità e castità
prof. Giorgio CARBONE
Il corso si propone di illustrare le diverse opinioni oggi diffuse sulla sessualità, nelle sue diverse accezioni, biologica, psicologica e comportamentale. Queste saranno valutate alla luce del magistero della Chiesa cattolica. Il corso si propone, poi, di chiarire la relazione tra castità, bellezza spirituale e dominio di sé nella carità.

Le costanti del «sacro e del «santo» nei sacramenti e nei sacramentali. Prospettive teologiche
prof. Paolo CALAON
Il seminario intende offrire, nell’ampio panorama delle riflessioni di teologia sacramentaria, alcune prospettive atte ad individuare le costanti del «sacro» e del «santo», partendo dall’analisi dei testi e dei riti di sacramenti e sacramentali. Analizzati gli elementi fondamentali e gli ambiti della ricerca, saranno offerte indicazioni ad una visione prospettica e poliedrica che tenga conto di riflessioni di antropologia teologica, sacramentaria e liturgica verso uno sguardo unitario e mistagogico.